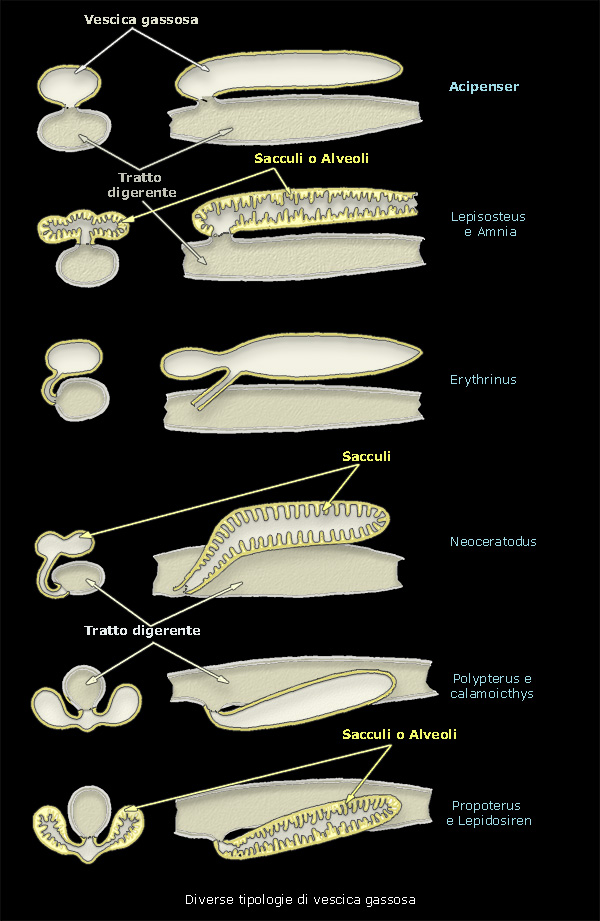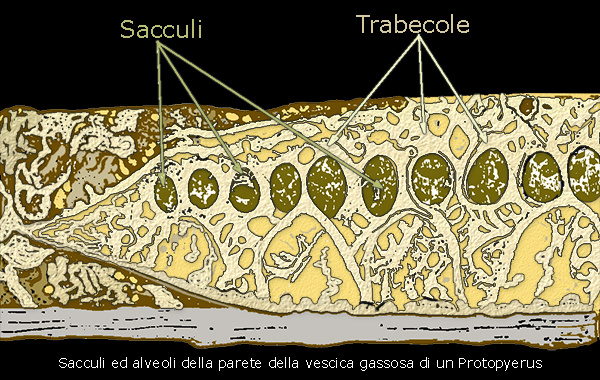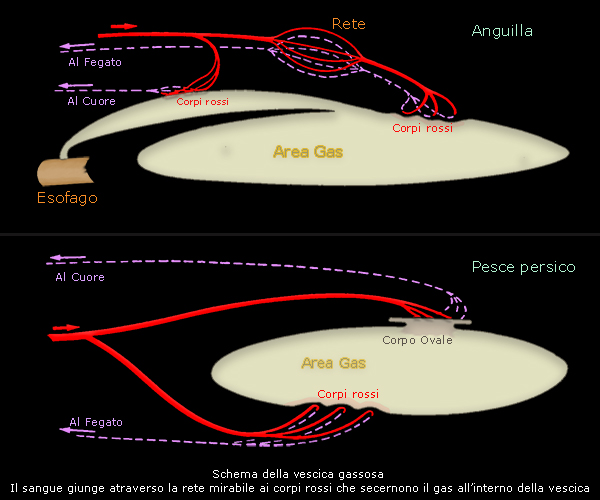|
Pesci -
Organi
|
|
Vescica Natatoria o Gassosa |
La vescica natatoria è presente durante la vita embrionale di quasi
tutti i vertebrati, sotto forma d’evaginazione impari della faringe o
esofago, si differenzia come organo respiratorio (polmoni) oppure, nei
pesci, come organo idrostatico.
È una struttura che non ha
analogie con altri gruppi di vertebrati. Embriologicamente fa parte del
digerente perché trae origine dalla parete dorsale dell’intestino
faringeo a cui può restare unito mediante un dotto pneumatico aperto
nei pesci fisiostomi (Ciprinidi e Salmonidi) oppure
obliterato e chiuso
nei pesci fisioclisti (Percidi e Gadidi).
Nasce inizialmente come un
organo respiratorio nel senso che nei periodi in cui si ha una scarsa
ossigenazione dell’acqua, riempito d’aria atmosferica tramite la
faringe, coadiuva l’attività respiratoria delle branchie, ma non in
misura tale da permettere all’animale la vita fuori dell’acqua.
Una
funzione analoga è ancora svolta in alcuni Attinopterigi molto arcaici
delle acque dolci Nord Americane (Lepisosteus e Amia) nei quali la
parete della vescica è alveolata (e non liscia) e ripiegata con aumento
della superficie respiratoria.
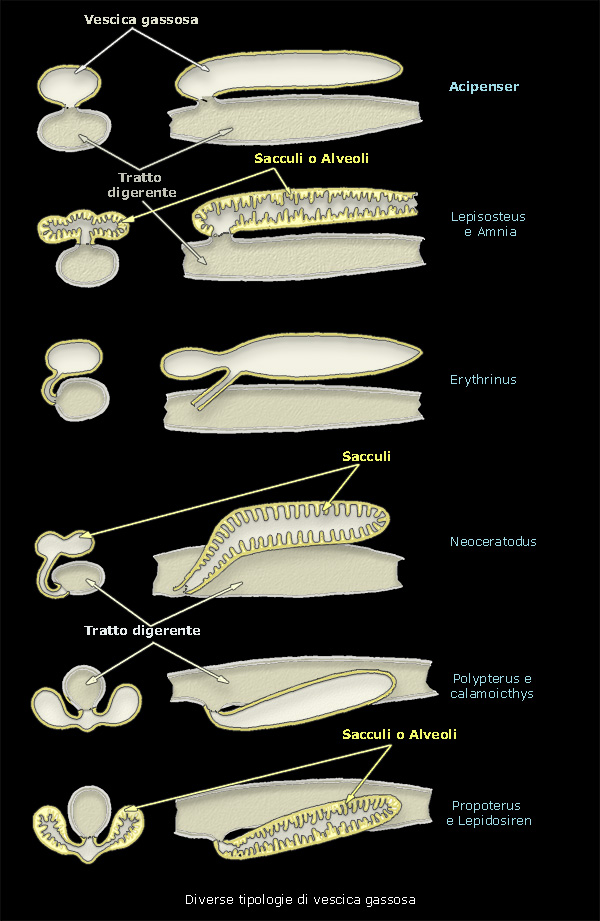
Un aspetto simile, alveolato, ed una funzione respiratoria ancora più
vicina al tipo polmonare, esiste per la vescica natatoria dei Dipnoi (Sarcopterigi).
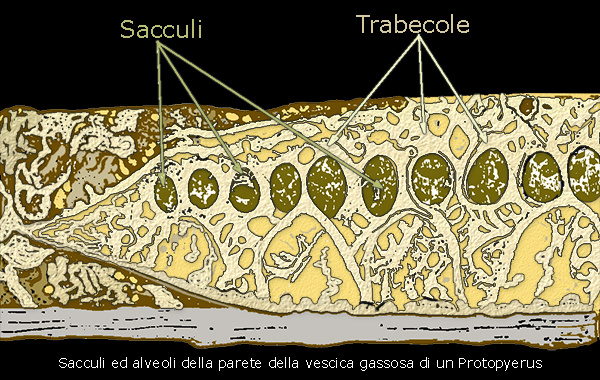
Negli Storioni ed in tutti i Teleostei più evoluti, la vescica natatoria
ha un diverso significato funzionale. È sempre unica, si trova sulla
linea mediana del corpo, dorsalmente all’intestino in sede
retroperitoneale.
Nasce di solito dorsalmente al faringe ed ha la
funzione d’organo idrostatico e di sensibilità idrostatica.
Macroscopicamente ha l’aspetto di un sacco con le pareti trasparenti
(trota o carpa) o perlacee (pesce gatto), situato fra la colonna
vertebrale e il tubo digerente.
Anche la forma può variare. Nei salmonidi
è formata da un unico scomparto. Nei ciprinidi è divisa in due lobi
(anteriore e posteriore), dove l’anteriore preme contro il labirinto
dell’orecchio interno tramite una catena d’ossicini (derivati dalla
modificazione d’alcune vertebre) costituenti l’Apparato di Weber. Questo
stabilisce una correlazione fra regolazione idrostatica fornita dalla
vescica natatoria e la regolazione dell’equilibrio e della posizione del
pesce attuata dall’orecchio interno e dal sistema della linea laterale.
Alcuni Teleostei possono mancare di vescica, come ad esempio forme
strettamente adattate alla vita nei fondali.
Nei Pleuronettiformi
(sogliole e rombi) dove l’adulto bentonico è privo di vescica natatoria,
ma ne sono provviste forme giovanili pelagiche, buone nuotatrici.
La
vescica natatoria permette al pesce di variare il proprio peso specifico
dando la possibilità di stazionare senza sforzo alla profondità
desiderata. L’aumento e la diminuzione di volume della vescica gassosa e
quindi la variazione di peso specifico del pesce e della conseguente
spinta idrostatica dipende principalmente dalla secrezione e dal
riassorbimento di gas (O, N, CO2) da parte di particolari
strutture poste nella parete della vescica natatoria.
Per la produzione
provvedono i corpi rossi che è una formazione ghiandolare
irrorata da una rete mirabile di capillari arteriosi e venosi in
intimo contatto, mentre il riassorbimento è effettuato dal corpo
ovale, una struttura specializzata che può aprirsi o chiudersi grazie
ad uno sfintere. Questa regione è molto assottigliata; con un complesso
di capillari separato dal lume della vescica da un epitelio formato da
un unico strato di cellule. I capillari di quest’area provengono dalle
arterie intercostali, mentre il drenaggio è operato dalle vene
cardinali.
Il corpo ovale è circondato da uno sfintere che controlla la
quantità dei gas da riassorbire attraverso la sua dilatazione o
contrazione. In questo modo il diverso grado d’apertura di questo
orifizio esporrà una maggiore o minore quantità di gas alla regione dei
capillari deputata al riassorbimento.
La rete mirabile è formata da vasi
capillari e venule che hanno la caratteristica di essere disposte
perpendicolarmente rispetto alla parete della vescica natatoria. Il
sangue giunge a questa struttura dall’aorta dorsale per mezzo di una
branca della celiaco-mesenterica ed è drenato da un ramo della vena
porta renale.
Nell’anguilla più di 100.000 arteriole ed un numero
leggermente inferiore di venule danno origine a questo complesso
vascolare che può raggiungere anche una superficie totale di 2 metri
quadri dove i vasi si trovano opposti gli uni agli altri.
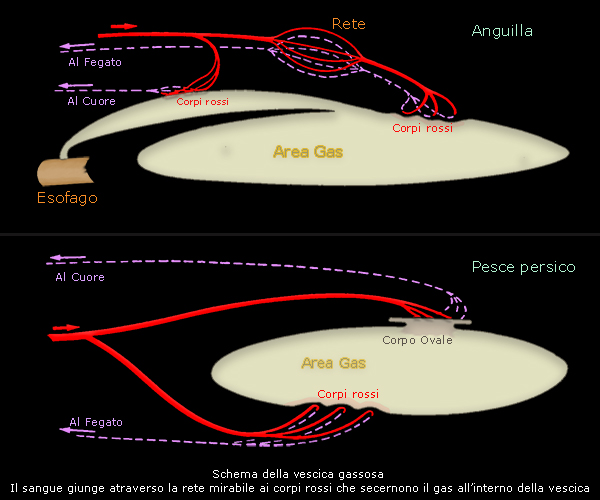
Il sangue arterioso che va alla vescica natatoria ed il sangue venoso
sono in intimo contatto in modo da permettere la diffusione di certe
sostanze da una parete all’altra secondo il gradiente di concentrazione.
In questo caso l’ossigeno disciolto nel sangue è trasferito dai
capillari alla parete della vescica natatoria con alta tensione. Le
cellule epiteliali una volta ricevuta quest’alta concentrazione
d’ossigeno, la trasferiscono all’interno della vescica natatoria.
Questo
processo risulta dalla formazione di piccole bollicine di gas a livello intracellulare che poi sono trasferite all’interno della vescica stessa.
Queste cellule epiteliali hanno la caratteristica d’essere impermeabili
ai gas disciolti e possono secernere solo bollicine. In questo modo
rappresentano una barriera alla diffusione dei gas: impediscono la
fuoriuscita del gas dalla vescica natatoria ai capillari dell’epitelio
ed alla rete mirabile.
Questo è il meccanismo:
-
La vescica si dilata
(secrezione di gas) si ha un aumento di volume con risalita in
superficie
- La vescica si comprime (riassorbimento o uscita
di gas) si ha una diminuzione di volume e discesa in profondità.
È
presente per lo più e quasi sempre, nei pesci d’acqua dolce che
sostiene meno il corpo rispetto alla più densa acqua marina.
La densità di un pesce è 1,076 ed è maggiore di quella dell’acqua che è
di 1,005 per litro d’acqua dolce e 1,026 per quella marina. Al fine di
ridurre al minimo il suo peso totale e di spendere meno e per mantenere
il corpo in posizione che il pesce deposita a livello epatico e
muscolare grassi e oli oppure usa un’inclusione di gas.
La vescica
natatoria di un teleosteo è un organo che ha la funzione di rendere la
densità del corpo più simile a quella dell’acqua circostante.
La vescica
in molti fisiostomi è riempita d’aria atmosferica dopo il riassorbimento
del sacco vitellino; infatti, questi pesci da adulti sono in grado di
riempire inizialmente la vescica senza potere accedere all’aria
atmosferica (trote e salmoni).
Nell’acqua e nel sangue arterioso dei
pesci, la pressione parziale dell’ossigeno e dell’azoto sono
rispettivamente di 0,2 e di 0,8 Atm mentre all’interno della vescica può
arrivare ad una pressione parziale dell’Ossigeno di
100 Atm e per l’Azoto di 20 Atm.
La capacità di concentrare i gas è una proprietà unica di quest’organo.
Nei pesci con vescica la produzione e l’assorbimento di
gas è un processo fisiologico che però presenta dei limiti di velocità
per quanto riguarda il cambiamento di posizione in profondità.
I pesci fisiostomi sono in grado eliminare l’eccesso di gas attraverso il dotto
pneumatico ed aggiustare la pressione; per i fisioclisti ciò non è
possibile ed il gas deve essere riassorbito.
Il gas (o i gas) presenti
all’interno della vescica natatoria sono veicolati a quest’organo per
mezzo del sangue ed a livello della parete vi sono regioni
vascolarizzate.
Il riassorbimento del gas da vescica gassosa avviene in diversi
modi:
- Diffusione
dei gas nei vasi sanguigni attraverso le pareti della vescica natatoria.
Tranne che nella parete dove è presente il complesso ghiandolare che
secerne i gas (alcuni pesci della famiglia Scombroidei)
-
Per mezzo di una particolare rete di
capillari specializzata nel riassorbimento in alcuni casi
connessa al complesso secernente il gas. In questo modo
affermeremo che quando è funzionante la struttura che secerne il
gas si ha un collassamento del by-pass arterioso e viceversa.
È il più frequente nei pesci con vescica natatoria formata da un unico
scomparto, ossia bilobata; c’è una struttura particolare a livello della
parete detto corpo ovale.
La vescica natatoria può anche avere una
funzione sonora, in quanto particolari muscoli, detti muscoli sonori,
sono in grado di produrre suoni. Questi muscoli sono inseriti a livello
della parete della vescica natatoria.
Tra i gruppi di pesce in grado di
produrre suoni vi sono i Clupeidi (con funzione simile ad una cassa di
risonanza).
Innervazione della vescica natatoria
L’innervazione di quest’organo è data dalle branche del vago del Ganglio
celiaco. Terminazioni nervose sono presenti nella regione deputata
al riassorbimento a livello del corpo ovale, nella rete e a livello
delle ghiandole deputate alla secrezione dei gas.
Nel polo cardiaco della
vescica natatoria vi sono numerose cellule gangliari.
Lo strato
muscolare della vescica ha delle afferenze nervose la cui funzione non è
ben nota.
Sembra che il processo di riassorbimento del gas sia stimolato
dalle catecolamine (la secrezione dei gas è aumentata dalla sua assenza).
U.
Fazzini
UniUD
2003-2004
|