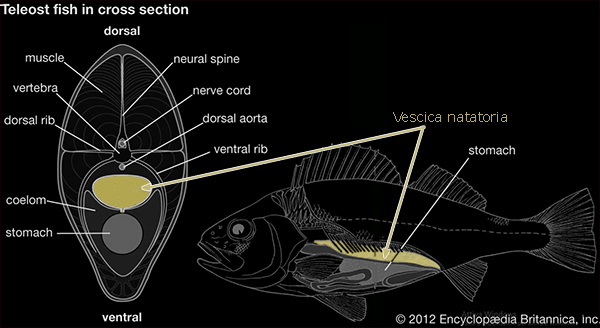|
Pesci -
Organi
|
|
Vescica Natatoria o Gassosa |
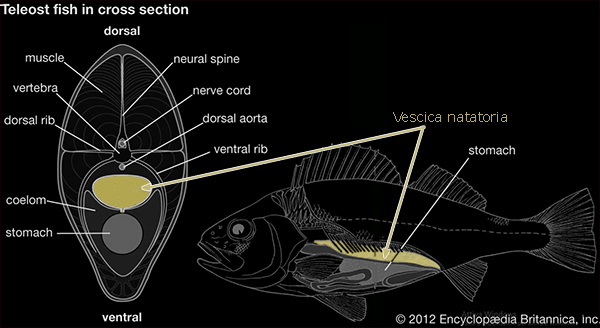
La vescica natatoria nasce nel corso
dell'evoluzione per permettere a determinati
organismi, quali vertebrati teleostei, movimenti
lungo una colonna d'acqua.
Nei pesci ancestrali tale vescica rivestiva un
ruolo primario per quanto concerne la
respirazione, funzione che ha perso nel corso
dei secoli.
Ciononostante alcuni pesci utilizzano la vescica
natatoria anche per respirare,
limitatamente
alle acque dolci scarsamente ossigenate, grazie
al fatto di possedere arterie polmonari già
vascolarizzate; quindi non necessitano di
assimilare gas, come sono soliti fare gli
animali che vivono in habitat con forti
concentrazioni di ossigeno.
Esistono due tipi diversi di vesciche
natatorie: se la stessa risulta connessa al
tratto gastro-esofageo il pesce sarà di tipo
fisostoma se invece non risulta connessa sarà
fisoclisti. In alcuni ordini,
come quello dei Perciformi, la
comunicazione tra
vescica gassosa e tubo digerente scompare
durante lo sviluppo.
La funzione della vescica natatoria è quella di
regolatore
idrostatico, grazie
al
graduale riempimento e svuotamento
dei gas (per
questo motivo è denominata anche gassosa); ciò fa
variare la densità specifica del corpo del
pesce, favorendo la galleggiabilità
del pesce e la capacità di spostarsi più o meno velocemente
in senso verticale, da acque profonde alla
superficie e viceversa.
La vescica natatoria è generalmente unica e
posizionata posteriormente rispetto
all'intestino, cui è collegato tramite il
dotto pneumatico; ha la foggia di una sacca
membranosa (in età adulta) il cui sviluppo ha
origine dall'esofago per poi
articolarsi in direzione caudale.
Il riempimento della vescica
avviene attraverso scambi gassosi col sangue, in
un organo particolare detto
corpo rosso o rete
mirabile.
Nella rete mirabile
(un denso gomitolo di
capillari disposti l'uno
contro l'altro) viene
applicato lo scambio in controcorrente,
grazie al quale è possibile concentrare l'ossigeno a valori di
tensione più elevati di quelli dell'acqua
circostante.
I gas si
muovono dal sangue in uscita
verso il sangue in entrata, non diversamente al
processo di scambio di
gas che avviene nelle branchie.
Il sangue che
lascia l'area trasporta gas alla stessa
pressione trovata nella vescica.
I globuli rossi aumentano il processo
rilasciando composti che aumentano il livello di ossigeno
del sangue.
Quando la pressione del gas nei
globuli supera quella della vescica, il gas si
trasferisce nella vescica.
Acquisto e rilascio
non è immediato; la vescica può
scoppiare quando un pesce
catturato a grande profondità viene trasferito
troppo velocemente alla superficie.
La composizione
dei gas all'interno della vescica è all'incirca
quella
dell'aria.
La vescica dei pesci d'acqua
dolce raggiunge il 7-11% del
volume del corpo, mentre quella
dei pesci marini il 4-6%.
La forma differisce da specie a specie: i
salmoni hanno una vescica uniloculare, e i
ciprinidi biloculare; alcune specie
come gli scazzoni, ne sono, invece,
sprovviste.
Nei ciprinidi, la sezione anteriore è unita
all'apparato stato-acustico con una serie di
ossicini, denominato ossicini di Weber.
Questo dispositivo consente ai pesci di
registrare le variazioni di pressione
atmosferica ed idrostatica.
Inoltre, lo spettro auditivo dei ciprinidi è
molto più esteso di quello degli altri pesci: la
loro vescica natatoria funziona, infatti, come
un amplificatore delle onde sonore.
In determinate specie, ha anche la funzione di
risuonatore, amplificando i suoni emessi.
Esiste una correlazione tra la forma della pinna caudale e
la presenza della vescica gassosa. Gli Squali e gli antichi Placodermi presentano una caudale di tipo eterocerco e sono o
erano sprovvisti di vescica natatoria. La conformazione
asimmetrica della coda e la posizione delle pinne pari,
permettevano a questi Pesci di mantenere un nuoto più o meno orizzontale
senza farl precipitare verso il fondo a causa
del loro peso.
Con la
presenza di un organo idrostatico, si ha il passaggio verso una
coda di tipo omocerco, simmetrica almeno esternamente.
AA.VV
|