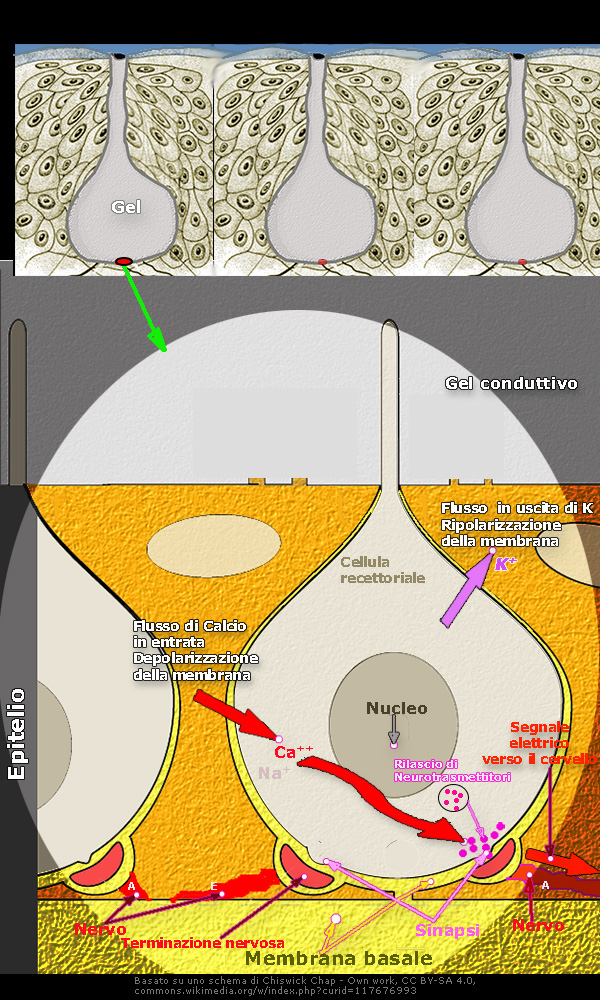|
 |
Pesci - Altri Organi - Organi di senso
|
|
Chemorecettori
Chemotrasduzione |
I Chemiorecettori fanno parte
delle categorie principali dei ricettori sensoriali, distinti in base al tipo di segnale a cui rispondono
(Nocicettori, Termocettori, Meccanocettori, Recettori elettromagnetici,
e Chemioricettori)
Un chemiorecettore è un recettore sensoriale all'interno di un
organo microscopico, fatto da vasi sanguigni e terminazioni
nervose in grado di rispondere a stimoli chimici, che innesca un
processo sensoriale fra i più primitivi.
Potenziale di ricettore
I potenziali d'azione sono
segnali elettrici che possono viaggiare lungo un fibra nervosa. Quando i recettori sensoriali percepiscono uno stimolo si
ha un cambiamento della permeabilità della loro membrana, determinando
l’apertura di canali ionici e quindi un cambiamento
del potenziale, che una volta superato un determinato valore di soglia
innesca lungo la fibra nervosa un
Potenziale d'azione.
La
frequenza del Potenziale d'azione aumenta in modo direttamente
proporzionale all'ampiezza del Potenziale di recettore, la quale aumenta
in base all'intensità dello stimolo ricevuto. Quest'ultimo incremento è
rapido per gli stimoli deboli e più lento per gli stimoli intensi.
Chemiorecezione
I pesci hanno sistemi chemiosensoriali respiratori, gustativi
e olfattivi che rilevano segnali chimici idrosolubili.
La chemorecezione è la capacità fisiologica
grazie alla quale i pesci rivelano informazioni chimiche presenti
nell'ambiente o nel proprio corpo.
La chemorecezione respiratoria principalmente nelle branchie rileva
cambiamenti nei livelli di ossigeno,
anidride carbonica e ammoniaca.
La chemorecezione gustativa, che coinvolge diversi
geni recettori del gusto, è principalmente coinvolta nell'assaggio
degli alimenti.
Le papille gustative consentono di rilevare sostanze
chimiche per trovare individui con cui accoppiarsi, evitare predatori.
La chemiorecezione olfattiva, che coinvolge tra 15 e 150
geni recettori olfattivi, è coinvolta in
funzioni biologiche come l'approvvigionamento di cibo, il
riconoscimento di pericoli, la discriminazione delle specie, il controllo del
comportamento sociale,
comportamento riproduttivo e migratorio.
L'olfatto percepisce sostanze gassose che raggiungono i recettori olfattivi attraverso l'aria.
Un chemiocettore fondamentale è l'epitelio olfattivo.
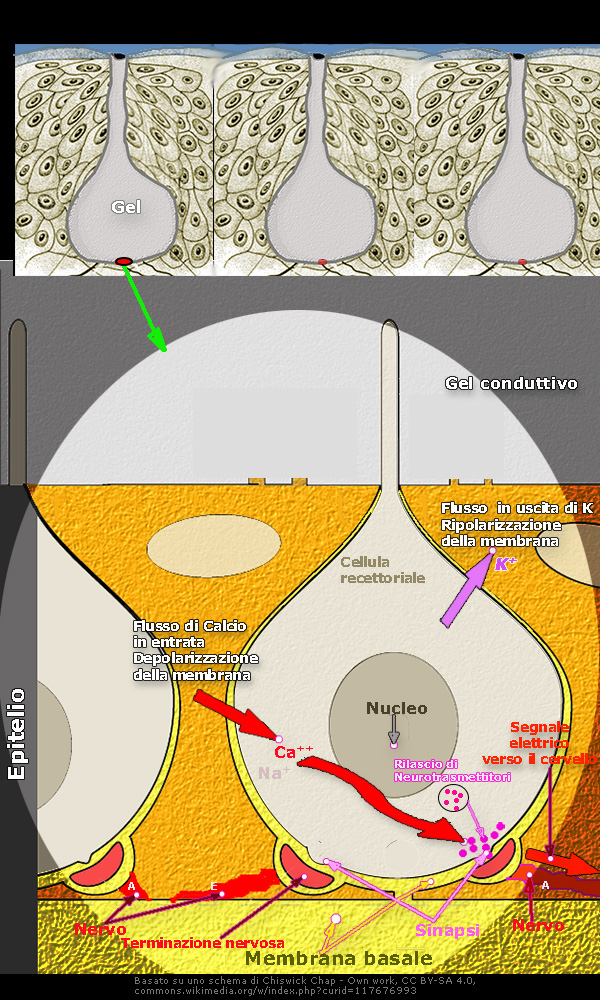
Chemotrasduzione
La chemotrasduzione è un processo attraverso il quale uno stimolo
chimico esterno a una cellula viene convertito in un segnale interno
a essa, ossia in una risposta cellulare.
In particolare, la chemotrasduzione olfattiva e quella gustativa sono processi
attraverso i quali le cellule recettoriali olfattive e gustative
convertono il contatto con specifiche sostanze chimiche in segnale
nervoso: solo le molecole con caratteristiche tali da poter essere
trasdotte dalle cellule recettoriali olfattive o gustative evocano
sensazioni olfattive o gustative.
La chemotrasduzione è effettuata
anche da cellule nocicettive, sensibili a stimoli chimici, che
evocano sensazioni dolorifiche, e da cellule non sensoriali, che
fungono da sensori per molecole quali CO2 o O2, allo scopo di
mantenere sotto controllo le variabili cruciali per la sopravvivenza
dell’organismo.
Ogni senso ha recettori specializzati che convertono stimoli
specifici in segnali elettrici. Questi segnali vengono poi elaborati
dal cervello per creare la percezione del mondo.
Il gusto
Il gusto è il senso che ci permette di percepire
i sapori degli alimenti. I recettori del gusto si trovano
principalmente sulla lingua, ma anche sul palato e in altre parti
della bocca. I recettori del gusto sono organizzati in strutture
chiamate calici gustativi. Ogni calice gustativo contiene da 50 a
100 cellule gustative.
Queste cellule hanno recettori sulla loro
superficie che rispondono a specifiche molecole chimiche presenti
nel cibo.
Per l'uomo, ci sono cinque gusti primari: Dolce, Salato, Acido.
Amaro. Umami (sapore del glutammato, spesso descritto come
"saporito" o "carnoso")
Quando le molecole del cibo si legano ai
recettori sulle cellule gustative, queste cellule generano segnali
elettrici che vengono inviati al cervello attraverso i nervi
gustativi.
Il cervello interpreta questi segnali come sapori.
Le percezioni gustative dei pesci, a livello
buccale, stimolano la contrazione della muscolatura viscerale della
bocca e della faringe, (masticazione, deglutizione, rigetto) la
separazione dei due sensi resta sempre legittima anche se si considera
il sistema gustativo "cutaneo" che ha le medesime vie nervose centrali
del gusto buccale.
Il gusto sembra esser ben
sviluppato in tutte le specie di pesci, anche se in misure diverse
L'olfatto contribuisce
in modo significativo alla nostra percezione del sapore del cibo.
L'olfatto
L'olfatto è il senso che permette di percepire gli
odori.
I recettori olfattivi si trovano nella regione
dell'epitelio olfattivo. L'epitelio olfattivo contiene milioni
di neuroni olfattivi. Questi neuroni hanno ciglia sulla loro
superficie che si estendono nel muco che riveste l'interno del naso.
Le molecole odorose si dissolvono in questo muco e si legano ai
recettori sulle cilia.
Quando una molecola odorosa si lega a un
recettore, il neurone olfattivo genera un segnale elettrico. Questi
segnali vengono inviati direttamente al bulbo olfattivo nel
cervello, e da lì ad altre aree cerebrali coinvolte nella percezione
degli odori e nella memoria.
Nell'uomo, l'olfatto è strettamente legato alla memoria e
alle emozioni. Questo perché le aree del cervello che elaborano gli
odori sono direttamente collegate con il sistema limbico, che è
coinvolto nella memoria e nelle emozioni.
Le percezioni olfattive dei pesci stimolano
soprattutto delle reazioni globali che interessano la muscolatura
somatica, direzione verso la fonte dell'odore o in direzione opposta
(attività di ricerca o di fuga).
Presso i pesci macrosmatici, che vivono nel fango o
nella penombra (anguilla,conger,) l'odorato ha un peso preponderante nel
comportamento della ricerca del cibo; nei pesci che vivono in acque
limpide (trota,perca) l'odorato, anche se fine, non interviene che nello
scatenare le reazioni di allarme.
Infine nei pesci microsmatici la
ricerca del cibo è affidata solo alla vista.
La vista
L'occhio è l'organo sensoriale specializzato nella
ricezione degli stimoli luminosi. La luce entra nell'occhio
attraverso la cornea, una membrana trasparente che protegge l'occhio
e focalizza la luce. Dietro la cornea si trova l'iride, un muscolo
circolare che controlla la quantità di luce che entra nell'occhio
regolando l'apertura della pupilla. La luce passa poi attraverso il
cristallino, una lente biconvessa che mette a fuoco l'immagine sulla
retina. La retina è lo strato più interno dell'occhio ed è composta
da fotorecettori, cellule specializzate che convertono la luce in
segnali elettrici.
Ci sono due tipi di fotorecettori:
● I coni: sono
responsabili della visione a colori e della visione dettagliata in
condizioni di luce intensa. Ci sono tre tipi di coni, ciascuno
sensibile a una diversa lunghezza d'onda della luce (rosso, verde e
blu).
● I bastoncelli: sono responsabili della visione in condizioni
di scarsa luminosità e del rilevamento del movimento. Sono più
sensibili alla luce rispetto ai coni ma non possono distinguere i
colori.
I segnali elettrici generati dai fotorecettori vengono
elaborati da altre cellule della retina e poi trasmessi al cervello
attraverso il nervo ottico. Il cervello interpreta questi segnali
per creare la nostra percezione visiva del mondo.
L'udito
L'orecchio
è l'organo sensoriale responsabile dell'udito e dell'equilibrio.
È
diviso in tre parti:
● Orecchio esterno: comprende il padiglione
auricolare e il canale uditivo. Il padiglione auricolare raccoglie
le onde sonore e le dirige verso il canale uditivo.
● Orecchio
medio: contiene il timpano e tre piccole ossa chiamate ossicini
(martello, incudine e staffa). Le onde sonore fanno vibrare il
timpano, e queste vibrazioni vengono amplificate e trasmesse dagli
ossicini all'orecchio interno.
● Orecchio interno: contiene la
coclea, un organo a forma di chiocciola riempito di liquido.
All'interno della coclea si trova l'organo del Corti, che contiene
le cellule ciliate, i recettori sensoriali dell'udito. Le vibrazioni
sonore fanno muovere il liquido nella coclea, stimolando le cellule
ciliate. Queste cellule convertono le vibrazioni meccaniche in
segnali elettrici che vengono inviati al cervello attraverso il
nervo acustico. Il cervello interpreta questi segnali come suoni.
L'orecchio interno contiene anche il sistema vestibolare,
responsabile del senso dell'equilibrio. Questo sistema è composto da
tre canali semicircolari e due organi otolitici (utricolo e sacculo)
che rilevano i movimenti della testa e la sua posizione rispetto
alla gravità.
Chemoreception in Fishes
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264086.013.333
Published online: 25 March 2021
Integrazioni con AAVV
|